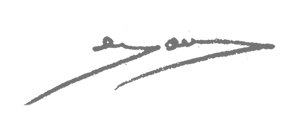Cenae Reliquiae: dagli scavi di Pompei agli allestimenti di Joan Crous
di Daniela Scagliarini
Quando ho visto, nel suo atelier tra i boschi dell’appennino bolognese, le cene di vetro di Joan Crous, fragili, luminose e insieme vetuste come se avessero attraversato tempi lunghissimi, non ho potuto non riconoscervi il vetus et novum del reparto archeologico appena messo in luce.
Joan è un artista colto, con una solida formazione di studi storici, che certamente hanno sostanziato il suo parallelo itinerario di artista senza togliergli la freschezza fantastica e conferendogli un’intensa capacità di suggestione e di evocazione. Si ha l’impressione che l’artista riesca ad entrare, con un suo itinerario intuitivo, nella turris eburnea del metodo e delle tecniche professionali dell’archeologo, per creare oggetti sospesi tra passato e presente.
Non intendo certo formulare un giudizio critico, per cui non ho alcuna competenza, ma solo rilevare che Joan è riuscito a trasferire nella sua opera, con straordinaria levità, le suggestioni e le riflessioni che accompagnano l’oggetto archeologico, in particolare l’oggetto “pompeiano”.
Non credo che sia un caso se Joan usa le due tecniche di “perpetuazione” che caratterizzano i rinvenimenti pompeiani: il calco, per riprodurre le forme, e la sostituzione del materiale organico con altra materia, il vetro, nel suo caso. Ottiene così un effetto di “vita interrotta”, che non può non ricordare le tracce della quotidianità troncata e conservata, dell’effimero sigillato e perpetuato della catastrofe che costituiscono l’ossimoro che continua a stupire e a emozionare lo scopritore e il visitatore delle città vesuviane.
Fra le espressioni della quotidianità, Joan ha scelto il momento del pranzo, che ha una enorme efficacia evocativa. A Pompei, com’è noto, il contesto documentario è unico al mondo per abbondanza di dati (si pensi solo agli affreschi, che concentrano la massima parte della nostra conoscenza della pittura antica); le ultime ore della città sono testimoniate con drammatica evidenza dai calchi di corpi degli uomini e degli animali, ottenuti, dalla seconda metà dell’ottocento, colando gesso nelle cavità lasciate nella massa vulcanica dai resti organici; e lo stesso ingegnoso sistema ha restituito le impronte di piante, mobili, porte, finestre, riproducendo così gli arredi di stanze e giardini, con una completezza eccezionale.
Eppure, tra tante eccezionali testimonianze, forse niente riesce a comunicare in modo così immediato e suggestivo la fragilità e la resistenza dell’uomo come i resti delle mense pompeiane: i servizi da tavola pregiati, in argento e in ceramica fine, ben riposti negli armaria e nelle cellae, talora frettolosamente occultati per essere recuperati dopo il cataclisma, ancor più le pentole, le stoviglie e i cibi (le uova conservate nell’argilla, le noci, le granaglie, il pane “a rosetta” così banalmente simile a quello di oggi) riapparsi nei triclini e nelle cucine a testimoniare il pranzo del 24 agosto del 79 d.C. Ma le suggestioni suscitate dalle Cene di Joan Crous non finiscono qui e rievocano – più concettualmente che fisicamente – anche un’altra del tutto diversa manifestazione dell’arte classica, che certamente Joan conosce, perché è un bravissimo mosaicista. Plinio il Vecchio (Naturalis historia, XXXVI 184) racconta che un famoso e abilissimo mosaicista di Pergamo, Sosos, realizzò nel II sec. A.C. un mosaico pavimentale per sale da pranzo che riproduceva asàrotos òikos (“stanza non spazzata”), come se i resti del banchetto coprissero il pavimento. Ne conosciamo alcune repliche o piuttosto variazioni sul tema: una è ad Aquileia, un’altra, firmata dal greco Heraclitos, nel museo Vaticano Lateranense: tessere minuscole “dipingono” valve di molluschi, gusci di lumache e di ricci di mare, chele di crostacei, lische di pesce, ossa di volatili, frutti, e anche di un topolino che approfitta dell’occasione. Il tema è qualcosa di più di un divertente trompe – l’oeil. I convitati, prima di iniziare il pranzo, ne avevano davanti agli occhi la conclusione: una variatio meno austera del monito sulla caducità umana (gli scheletri rappresentati nei mosaici o sulle coppe per il vino: hoc erimus cuncti, così saremo tutti) che spesso veniva introdotto nei banchetti forse più per esorcizzare la fine che per ispirare moderazione. A mano a mano che il banchetto procedeva, l’immagine musiva che ricopriva il pavimento e la scena reale tendevano ad assimilarsi, l’esperienza effimera del convito veniva a coincidere con la sua durevole rappresentazione figurata. Il mosaico, con la sua miriade di Cenae reliqiae, restava a ricordare e ad anticipare tutti i banchetti, in momenti in cui gli uomini cercano di trasformare l’azione basilare dell’assunzione di cibo in convivium, l’atto di “vita comune” per eccellenza.